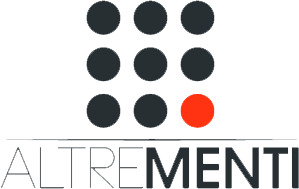Fare i conti con la perdita della propria vita

Fondatrice della psicotanatologia, Elizabeth Kϋbler Ross, una psichiatra svizzera traferitasi negli Stati Uniti, ha trascorso la propria vita lavorativa al capezzale dei morenti. Nel suo libro ‘La morte e il morire’, sviluppa il tema relativo al lavoro del lutto che ogni essere umano deve affrontare quando sa di perdere la propria vita. E’ un congedo che segue un processo inarrestabile e progressivo e, quasi sempre, procede di pari passo con la perdita delle proprie funzionalità corporee che ne scandiscono i tempi.
A differenza degli altri lutti che si vivono nell’esistenza, quindi, le sue fasi sono scandite da precisi cambiamenti fisici oggettivabili. E’ originato da una separazione che viene compiuta prima che l’evento luttuoso si verifichi e non successivamente, sia per il diretto interessato sia per i suoi familiari.
Questi ultimi hanno più strumenti a disposizione per scotomizzare la morte. Vanno dall’isolamento del malato, alla sua completa medicalizzazione fino all’esigenza spasmodica di tenere sotto controllo i dati nosologici, come se, al capezzale di un morente, per difesa, occorresse più fare che esserci. E’ proprio l’esserci che, soprattutto per i parenti, rimane estremamente difficile poiché induce a misurarsi con emozioni e sentimenti troppo grevi e numerosi per essere sopportati, soprattutto se si considera che possono essere ‘diluiti’ anche a seguito della morte del malato: il senso di colpa, l’impotenza, la tristezza, il dolore, la rabbia, il rimpianto.
Il malato, a differenza dei suoi parenti, deve misurarsi quotidianamente, e in ogni momento, con l’esame di realtà che gli è dato dalla propria condizione: sa di dover elaborare la propria morte e che non gli resta molto tempo per farlo. Benché, a tratti, la consapevolezza della propria situazione possa venir meno per difesa, segue un lavoro del lutto il cui procedere, secondo l’autrice, è scandito nelle fasi di seguito indicate. In linea di massima, si susseguono lungo un continuum ma non sono da escludere momentanei ritorni alle fasi precedenti:
- il rifiuto e l’isolamento;
- la collera;
- il venire a patti;
- la depressione;
- l’accettazione;
- la speranza.
Il rifiuto e l’isolamento. Il rifiuto è la prima difesa che viene messa in atto da chi è costretto a misurarsi con il verdetto di una malattia che non perdona. Coinvolge sia chi viene informato senza riserve all’inizio della propria malattia sia quelli che non ne vengono informati esplicitamente e che giungono più tardi ad ammettere il proprio stato. Può manifestarsi in maniere diverse che spaziano dal diniego temporaneo, che interessa chi è stato informato della propria condizione di salute prima che fosse pronto per affrontarla, alla necessità di iniziare un vero e proprio pellegrinaggio da un luminare ad un altro alla ricerca di uno specialista che spieghi meglio le cause della propria sintomatologia, fino al considerare la possibilità della (propria) morte per un po’ di tempo, con la necessità di dover accantonare questa considerazione per poter continuare a vivere. Il rifiuto consente al malato di raccogliere le forze, le energie e la capacità per trovare il coraggio di prendere atto della propria condizione.
Quasi sempre, il rifiuto è una difesa temporanea ed è seguito da una ‘parziale accettazione’, anche se non sono da escludersi considerazioni del malato sulla propria condizione presentata in maniera tale da far emergere un altro meccanismo di difesa: l’isolamento dell’affetto. Quest’ultimo può accompagnare il malato in tutto il decorso della sua malattia e si manifesta ogni qual volta il malato non riesce a rimanere in contatto con emozioni troppo dolorose.
Può accadere anche che il malato parli della propria situazione, dimostrando partecipazione, ma alterni a questi momenti periodi e frasi che tradiscano ancora il rifiuto. Nell’analizzare le reazioni del malato, non occorre considerare soltanto le sue resistenze ma anche quelle dei familiari, dei medici o del personale ospedaliero. Il malato, infatti, può sentirli non disponibili ad accogliere la sofferenza di cui è portatore, motivo per cui può sembrare non sia in contatto con ciò che prova. In realtà, potrebbe soltanto difendersi dalle conseguenze della solitudine a cui può costringerlo chi gli sta attorno perché non è in grado di sintonizzarsi empaticamente con i suoi sentimenti condividendoli ma, anzi, negandoli a sua volta.
La collera. La realtà prende il sopravvento e non può più essere rifiutata nella sua drammaticità. Sorgono l’invidia per le persone a cui non è toccato lo stesso destino e la rabbia, una collera che ‘viene proiettata in tutte le direzioni e sull’ambiente, a volte quasi a caso’ – scrive la Kϋbler Ross. E’ il momento in cui i medici, il personale infermieristico e l’intera struttura ospedaliera sono oggetto di un forte risentimento che necessita di altrettanto contenimento. Anche i parenti e gli amici vengono trattati con freddezza e con indifferenza, tanto che non è raro arrivino a sentirsi in colpa per l’atteggiamento che ha riservato loro il malato.
In questa fase, il malato prende coscienza della necessità di dover interrompere la stragrande maggioranza di tutte le attività a cui si è dedicato per una vita, la sua vita. Deve abbandonare i propri progetti, le proprie abitudini, i propri interessi per proiettarsi in un futuro in cui aleggiano ripetute analisi mediche, lunghi periodi di ospedalizzazione, cure interminabili, limitazioni della propria libertà, continue rinunce, dolore fisico e sacrificio. Queste fantasie sono pervasive e possono arrivare ad essere fortemente intrusive e portare chi le subisce a sentirsi escluso da un mondo che non gli appartiene, che pensa ad altro e dal quale teme di essere dimenticato. I familiari reagiscono personalmente a questa collera, rispondono comunque con rabbia ancora maggiore, giustificandola solo con il comportamento ostile del malato. Difficilmente, infatti, a loro volta, sono in grado di convivere con il timore della propria malattia e della propria morte, un timore messo in luce ed evocato dal malato stesso.
Il venire a patti. Superata la fase della rabbia, si presenta una fase di durata molto breve, nella quale prevale il senso del patteggiamento, di una vera e propria contrattazione con la vita. L’autrice la descrive facendo ricorso a numerose situazioni che richiamano al mondo infantile, a un atteggiamento regressivo o a una sorta di patto che il malato pensa di fare con Dio. ‘Se Dio ha deciso di togliermi da questo mondo e non risponde alle mie arrabbiate suppliche, forse, sarà meglio disposto se glielo chiedo con delicatezza’ – scrive Kϋbler Ross.
Si tratta di un periodo in cui la persona si impegna a ritardare mentalmente le conseguenze del verdetto, sembra fare un tentativo costruttivo di godersi quel che può, nel qui ed ora, senza troppo guardare avanti, anzi, calando il sipario su quello che lo attende. Gli esempi riportati dall’autrice fanno riferimento a una giornata piacevole trascorsa nella spensieratezza durante il matrimonio di un figlio, al cantare per l’ultima volta prima di un devastante intervento alla bocca, al godersi l’ultima volta di ciò che appassiona, liberati dal dolore o dal disagio fisico. Insomma, si tratta di patteggiare con la vita una sorta di dilazione dello scotto da pagare per la malattia che affligge. E’ chiaro che chi vive l’ultima volta non ne è mai appagato e che la speranza sia sempre e comunque quella di poter vivere ancora molte ultime volte.
La depressione. La depressione subentra quando la condizione fisica della persona inizia a peggiorare e i sintomi dell’ineluttabile malattia si fanno più evidenti, manifestandosi con il dimagrimento, con la debolezza, con l’astenia, con l’esigenza di nuovi interventi e terapie. A questa situazione si associano spesso la necessità di astenersi dal lavoro, l’incapacità di dedicarsi ai figli o di svolgere le più comuni attività. Insomma, si perde la propria autonomia e molto spesso si provano vergogna e senso di colpa per questo. E’ il momento in cui il malato inizia a riflettere dolorosamente sulla propria morte e a fare il lutto sulla propria separazione dalla vita.
In questo periodo, la depressione assume due connotazioni differenti. In un primo tempo, è ‘reattiva’, poi è ‘preparatoria’, secondo le definizioni della Kϋbler Ross. La reattiva è strettamente correlata alla perdita delle proprie funzionalità e, quindi, a quella della propria autostima: la persona si sente ancora insostituibile e si misura con la difficoltà ad adempiere ai propri compiti. La depressione preparatoria è, invece, dovuta al senso di perdita e di distacco nei confronti di tutto ciò che si sta per perdere. Ha la funzione di facilitare lo stato di accettazione e consente al malato di contemplare la propria morte imminente. Avviene quasi sempre nella più completa solitudine poiché chi sta attorno al malato tende, per difesa, a non essere empatico con le sue emozioni e lo incoraggia non tanto a pensare a ciò che perderà quanto a ciò che ancora sta vivendo. Questo atteggiamento discordante rispetto a ciò che sente lo affatica ed è in lui causa di maggiore dolore.
L’accettazione. La fase dell’accettazione non può certo essere considerata una fase felice ma è senza dubbio caratterizzata dalla mancanza di rabbia, di invidia, di depressione. ‘E’ quasi un ‘vuoto di sentimenti’, secondo la definizione dell’autrice. Il malato ha affrontato il lavoro del lutto e ‘contempla la sua prossima fine con un certo grado di serenità nell’attesa’. Il suo bisogno di sonno - che la Kϋbler Ross descrive come un sonno opposto a quello del neonato - fa pensare alla stanchezza e al senso di svuotamento descritto da Freud al termine del lavoro del lutto, quando tutte le energie libidiche si sono ritirate dall’oggetto perduto.
Il malato ha l’esigenza di ritirarsi, di stare in pace, di non essere coinvolto nelle problematiche della vita e del mondo esterno: ha bisogno di silenzio. Quella dell’accettazione è anche la fase in cui il malato è maggiormente in grado di fare comunicazioni significative, a patto di trovare qualcuno disponibile ad ascoltarlo profondamente, anche soltanto con un gesto o con lo sguardo, e a connettersi con il suo stato d’animo. Ci sono alcuni malati che raggiungono questo stadio con maggiore serenità. Sono quelli che possono concludere la propria vita ritenendo di aver assolto ai propri compiti, trovando nella propria esistenza un senso compiuto. Altri malati hanno bisogno di un maggiore aiuto da parte dell’ambiente esterno. Tutti, però, ritornano ad uno stadio di narcisismo primario, un periodo in cui sperimentano l’Io come il tutto.
La speranza. E’ la fase caratterizzata dalla maggiore compromissione fisica, quella che accompagna effettivamente alla morte. E’ tollerabile perché è caratterizzata dalla speranza in un miracolo della scienza, in una soluzione che possa dare un senso alla sofferenza provata. E’ il momento in cui ci si illude che l’incubo possa finire, che esistano ancora delle cure. Coinvolge anche le persone che hanno compiuto il loro lavoro di separazione dalla vita con il peggiore realismo ma che sono disponibili a pensare sia avvenuto un miracolo anche ‘semplicemente’ perché si sentono pronte a morire e non hanno più paura.
E’ la fase in cui parecchi malati chiedono di passare più tempo insieme ai propri familiari per ‘poter togliere la maschera e godere pienamente le ultime poche settimane insieme a loro’, come spiega l’autrice. E’ la fase della vera autenticità che consente di trovare davvero il senso del morire poiché il morire fa parte del vivere.
Da questo punto di vista, il monito della Kϋbler Ross è assolutamente chiaro e incisivo: ‘potrebbe essere utile che un maggior numero di persone parlasse della morte e del morire come parti intrinseche della vita, così come non si esita a parlare di qualcuno che aspetta un bambino. Se lo si facesse più spesso, non dovremmo chiederci se dobbiamo parlare con un malato di questo argomento o se dobbiamo aspettare l’ultimo ricovero’.